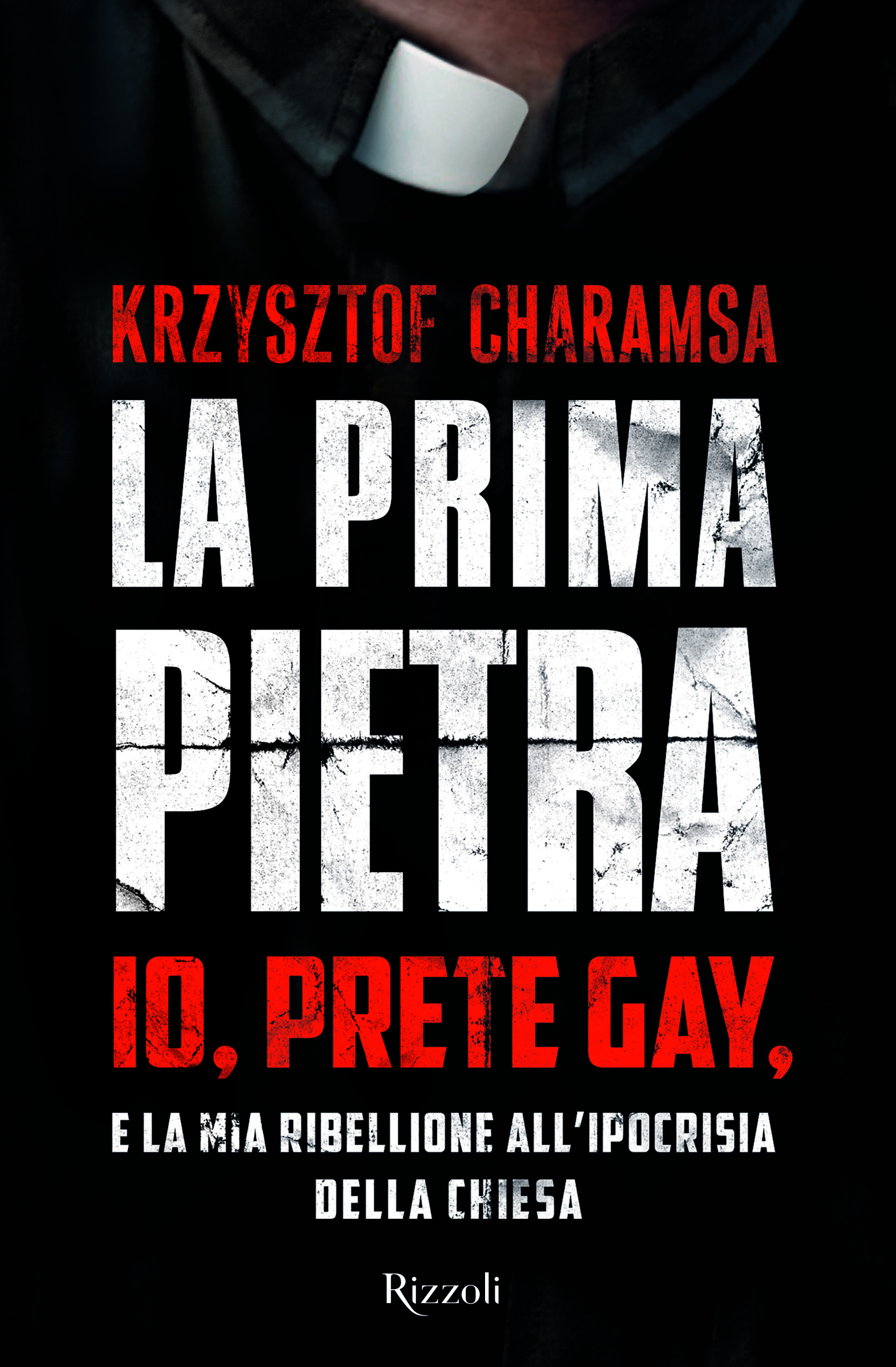Karim Franceschi – La mia guerra contro l’ Isis
No, non lasciamoci ingannare dalle apparenze. La religione non c’entra: «Mia madre è musulmana, io no». E nemmeno il fatto che la mamma sia marocchina, lui sia nato a Casablanca e mastichi qualche parola di arabo. Karim Franceschi è italiano, italianissimo. Anche al fronte, quando ha deciso di combattere per tre mesi contro l’Isis a Kobane il suo nome di battaglia era Marcello. Lì per tutti era L’italiano. E lì, tra i partigiani curdi, le sue poche parole di arabo non gli sono servite a molto. Capire che cosa spinga un ragazzo di 25 anni, cresciuto a Senigallia, ad imbracciare un kalashinov non è il primo motivo per leggere il suo libro, Il Combattente, (Bur Rizzoli, 17 euro). Semmai il secondo. Il primo è capire dall’interno con i suoi occhi, una guerra che ci riguarda sempre più da vicino. Ora Karim è appena tornato in Italia. Parla con la sicurezza di un uomo che ha visto la morte, e ne è sopravvissuto.
Karim, perché ha deciso di combattere a Kobane?
«È qualcosa che ha a che fare con la ricerca di mio padre, è morto quando io avevo 12 anni. Era stato partigiano, si chiamava Primo, oggi avrebbe quasi 90 anni. Mi manca molto. Non ho mai potuto confrontarmi, da uomo, con lui. Sin da piccolo mi ha trasmesso i suoi ideali e il senso della parola libertà. Solo che non sapevo bene qui in Italia che cosa dovessi fare per difendere davvero la libertà. Sin dai 19 anni frequento i centri sociali, cerco di impegnarmi in progetti di solidarietà. Ma il paradosso è che se vieni dalle case popolari come me, nei centri sociali ti guardano con…sufficienza. In effetti mi sono sentito più accettato tra i miei compagni curdi… Comunque questo per dire che ho avuto nel cuore sin da piccolo l’importanza della parola Rivoluzione. Ad un certo punto ho sentito che se volevo davvero trovare mio padre, se volevo davvero sentirmi un rivoluzionario, beh, dovevo andare lì dove oggi si combatte per difendere la libertà. Nel 2014 attraverso il progetto Rojava calling, ho aderito ad una missione umanitaria per portare aiuti alla popolazione della regione siriana del Rojava. Tornato in Italia ho sentito che non mi bastava più. E sono partito».
Usa spesso le parole rivoluzione, rivoluzionario. Ma che cosa vogliono davvero dire per lei?
«Quando contro corruzione e uso distorto del potere non bastano le riforme è allora che entra in gioco la rivoluzione, sei un rivoluzionario. Solo che ad un certo punto non può bastare parlarne soltanto. Io ho sentito il bisogno di andare a combattere con chi oggi davvero mette a repentaglio la sua vita per difendere la propria libertà. Anche perché, e lo abbiamo visto, quel fronte ci riguarda tutti. Se permettiamo che in una qualsiasi parte del mondo si diffonda terrore e oppressione, abbiamo perso.Tutti».
A gennaio 2015 è arrivato al fronte, subito l’addestramento tra i giovani partigiani del Ypg (Unità di protezione del popolo), dopo poche settimane la prima linea. La prima cosa che le hanno insegnato è stato come farsi saltare in aria nel caso in cui venisse catturato, per non finire prigioniero e magari uccidere anche qualche nemico con se stesso. È stato vicino a farlo. Così come ha visto cadere molti nemici e ha visto, tra quei corpi, molti tratti europei, altri foreign fighters come lei, ma sul fronte opposto, che combattevano per l’Isis. Si è spiegato che cosa li avesse spinti ?
«Quelli che vengono dallEuropa sono per lo più arabi e musulmani di seconda generazione. I genitori li hanno cresciuti e fatti nascere in Occidente, dove però loro hanno sentito l’ostracizzazione dello straniero, non si sono mai sentiti accettati del tutto. Pensate solo alla rappresentazione del musulmano negli ultimi quindici anni al cinema: è brutto, col turbante, cattivo e pure stupido. Ecco l’Isis ha offerto loro una nuova immagine del musulmano, forte e vincente. La xenofobia in Occidente li fa arruolare in Oriente».
O diventare terroristi come quelli delle stragi di Parigi?
«Certo. Un anno fa lo ignoravamo ma oggi noi tutti in Italia sappiamo che cosa è l’Isis. Ma il paradosso è che in Siria Daesh secondo l’acronimo arabo, ora è in ritirata. Grazie soprattutto alla lotta sul campo dei fratelli curdi che sono gli unici che combattono non in nome di una qualunque idea distorta della religione, ma in nome di valori laici e secolari come la libertà. E siccome lì l’Isis sta perdendo hanno cominciato ad attaccarci qui, nelle città occidentali».
Ma che cosa servirebbe per sconfiggere davvero lIsis?
«Una vera unione di tutte le forze democratiche presenti lì sul territorio. Oggi c’è una grande confusione. I curdi combattono contro Daesh e nel contempo vengono massacrati dal governo turco. Ho visto blindati con la bandiera nera passare il confine turco senza che nessuno li fermasse. I paesi del Golfo hanno finanziato i jidhaisti. Lo stesso Assad, il dittatore siriano, è l’erede di una dinastia messa al potere dallOccidente perché rappresentava una minoranza religiosa debole e dunque facilmente controllabile. L’ambiguità di tante forze in campo è imbarazzante. La religione è solo un pretesto, per loro. Non a caso sono vicino ai curdi che come me, non s’identificano in una religione. Pochi sanno poi che Raqqa, oggi ritenuta la capitale del Califfato, era una città all’avanguardia, governata dalla sinistra innovatrice».
Sul fronte a combattere racconta di molte donne.
«Sì, esiste un intero contingente curdo al femminile: combattono con coraggio e sono le prime martiri perché per farlo lasciano figli anche piccolissimi. Anche tra le foreing fighters però molte sono donne. La fortissima propaganda dell’Isis fa leva sull’uso e abuso del corpo delle donne in Occidente, dice loro che invece nel Califfato verranno rispettate e protette. Così si arruolano. Ma quando capiscono che è tutta una deprecabile mistificazione è troppo tardi per tornare indietro».
Una guerra anche molto mediatica è quella dell’Isis. Lì che immagini arrivano dell’Occidente?
«I titoloni da noi sull’emergenza immigrazione, la propaganda sulla chiusura delle frontiere fa il gioco dell’Isis. Nel Califfato fanno vedere le immagini dei naufragi, fanno vedere i titoli xenofobi e dicono alla gente: se partite morite e poi loro sono pure contenti perché siete morti lungo il viaggio».
Karim, ha sparato, ucciso, a volte senza vedere negli occhi il suo avversario a volte sì. Che cosa ha provato?
«Se le uniche armi che sei abituato a usare sono quelle di un videogioco, non ti lascia indifferente. Purtroppo il kalashnikov è un’arma molto facile da usare e anche da reperire. S’impara facilmente, è un gioco da bambini, insomma, sparare. Infatti, ahimé, la usano anche i bambini. Ecco se pensi che l’uomo che hai ucciso non ucciderà più donne e bambini, non torturerà, non martorierà i prigionieri, come ho visto fare, non ti chiedi più se sia giusto farlo o meno».
Che cosa ne pensa dei fatti di Colonia, le aggressioni contro le donne la notte di Capodanno, e la paura dello straniero che hanno innescato?
«Ne so poco perché ero in Siria in quel periodo. In generale il crimine è una questione personale, non ha a che vedere con la nazionalità di chi lo commette. E personalmente va punito».